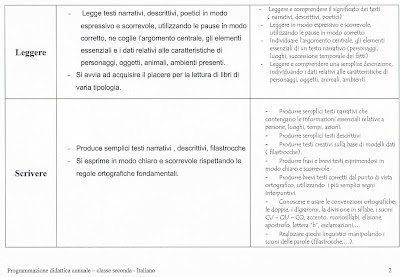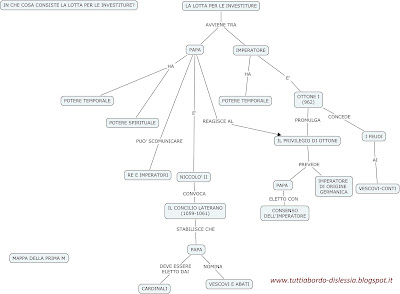Un viaggio tra remote città fantasma, dove aleggia ancora la speranza, e le nostre città, al cui posto sembra aver attecchito “l’indecenza della non rabbia, della non bestemmia, della rassegnata assuefazione”. Parole di De Andrè, attraverso le quali mettere in crisi il nostro presente.
La morte è l’ignoranza della vita:
quanti morti si aggirano tra i viventi.
Pitagora
1.
C’è Ruby. Ci sono Kelly e Magdalena, Virginia e Crystal. Sono decine, centinaia, migliaia. Ci sono Antelope, Chloride, Osiris, Ione, Hachita. E poi c’è Bodie, la mia preferita. Sono tutte città fantasma. Sperdute in spazi sconfinati, tra metropoli e piccoli centri di provincia, soltanto la costa occidentale degli Stati Uniti ne conta circa seimila, sempre in prossimità di miniere estinte. Finito l’oro, con la stessa rapidità con cui si erano insediati – costruendo case, chiese, spacci e saloon – minatori e avventurieri, con famiglie al seguito, abbandonavano tutto, tranne il necessario, per cercare benessere altrove.
Del loro passaggio, in questi centri, ai giorni nostri sopravvivono pochi edifici, utensili sparsi qui e lì, qualche indumento a evocare storie, in uno spazio sospeso e abbandonato a se stesso. Nessun restauro, nessun investimento di sostanza per preservare il valore storico di questi luoghi. Nel migliore dei casi sono solo circoscritti e soggetti a piccoli interventi di manutenzione per continuare lo status quo, che nella lingua dei pionieri suona arrested decay: ‘fatiscenza bloccata’. A pensarci: neanche tanto poco, considerando la condizione di fatiscenza invece progressiva in cui versano molti siti antichi italiani; e in ogni caso è il massimo di archeologia che ci si possa aspettare dagli americani, tutti volti al futuro come sono, attratti dai nuovi territori da esplorare, reali o metaforici.
Non c’è cinismo in questa tendenza. Né disinteresse per il passato. C’è semmai la convinzione di una totale subalternità delle cose e degli oggetti, ridotti al loro valore strumentale quando non ne hanno uno dichiaratamente artistico, a tutto vantaggio di una centralità piena dell’essere umano e delle sue esigenze. Le cose non contano, contano solo gli uomini, che preservano il passato nell’unica forma possibile, sia pure declinabile in vari codici, cioè il racconto: la narrazione. Il passato degli Stati Uniti coincide proprio con l’epopea, per quanto auto-assolutoria, della conquista del West, e – estremizzando – gli oggetti e gli ambienti di quella stagione non sono conservati nelle teche di un museo – che pure ovviamente ci sono – ma fermati per sempre nelle immagini del cinema: la forma più propria del racconto americano.
E infatti, quando ci si muove negli spazi di una qualunque di queste città fantasma non si ha la sensazione di essere in un luogo storico, ma sembra piuttosto di stare su un set cinematografico. Questo immediatamente predispone a una fruizione ludica, vitale, a dispetto della definizione “spettrale”. Nessuna paura, né desolazione: nessuna nostalgia passatista. Benché ci si ritrovi circondati da rovine, non si è mai sopraffatti da un senso di morte. Quelli che mancano non sono morti: se ne sono andati, e con le loro gambe. Questo è chiaro da subito anche quando non si conosce la loro storia: vien fatto di immaginarli a rinascere altrove, a costruire qualcosa di nuovo, proprio per evitare di morire incagliati in una dimensione superata dagli eventi. La loro assenza – il vuoto – non rappresenta una rinuncia: è una speranza. Esattamente ciò che manca nelle nostre città – a parte quella che portano con sé gli immigrati: non a caso gli unici che continuino a fare figli, in un paese di suo a crescita zero – apparentemente in piena attività ma popolate da individui che vivono la propria morte con “un anticipo tremendo”.
2.
La citazione è tratta dal Cantico dei drogati di Fabrizio De André, la cui ricerca poetica, si potrebbe dire, è quanto di più vicino allo spirito e alla curiosità dei pionieri americani. Ogni suo album è il risultato dell’esplorazione di un territorio nuovo (sempre in grado di fornire una chiave d’interpretazione del presente): i Vangeli Apocrifi nella Buona novella, l’America di Edgar Lee Masters in Non al denaro non all’amore né al cielo e quella del genocidio dei Pellerossa in Indiano (proprio il contraltare rimosso dell’epopea del West) o la cultura mediterranea in Crêuza de mä, solo per fare qualche esempio. Una quête colta e raffinata condotta con alcune costanti formali come l’ironia e tematiche come il concetto di morte, già evidente dal titolo del suo primo concept album: Tutti morimmo a stento.
La morte a cui si riferisce De André in quel contesto – e poi ancora nelle produzioni successive – non è quella “cicca, con le ossette”, come spiegava giovanissimo in un’intervista a Enza Sampò, ma “la morte psicologica, morale, mentale”. È l’assenza di speranza, quella che lo spaventa di più e che contrasta con la forza vivida dei suoi personaggi, che rivendicano i propri desideri, il diritto alle proprie fragilità, contro il conformismo opprimente delle logiche di potere. Personaggi vivi – vitali – anche quando sono “tecnicamente” morti come quelli di Spoon river che ci parlano dalle loro tombe.
Come il suonatore Jones, il primo che mi è venuto in mente, passeggiando per le vie di Bodie, qualche tempo fa: davanti a ciò che resta del vecchio saloon sembra infatti “di sentirlo / cianciare ancora delle porcate / mangiate in strada nelle ore sbagliate. / Sembra di sentirlo ancora / dire al mercante di liquore / “tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?”.
Jones me lo sono immaginato anche nel quartiere a luci rosse, di cui oggi a Bodie non sopravvive nulla se non la leggenda di Rosa May, che sembra venuta fuori anche lei da una canzone di De André. Rosa May è una puttana passata alla storia come eroina per aver accudito decine e decine di persone durante un’epidemia devastante. Il contributo alla salvezza dei suoi concittadini, nondimeno, non le garantì la sepoltura nel cimitero cittadino, precluso ai peccatori, nel gioco d’ipocrisie di quelli che durante il giorno la chiamavano “pubblica moglie” e che di notte la cercavano per soddisfare le proprie voglie. Con buona “pace terrificante” di tutti.
Anche questa citazione si deve a De André: un accostamento – sostantivo, aggettivo – su cui varrebbe la pena di soffermarsi, tenendo conto della selezione accuratissima delle parole in tutti i suoi testi e del valore che in essi è universalmente riconosciuto al concetto di pace. Incuriosisce che un libertario antimilitarista come lui – lo stesso che continua a commuovere generazioni di appassionati con la Guerra di Piero – possa considerare la pace terrificante.
La ragione è intrinseca al contesto in cui le due parole sono inserite con chiaro intento provocatorio. Si tratta della Domenica delle salme. Già dal titolo si capisce che, a più di vent’anni di distanza da Tutti morimmo a stento, De André ritorna a parlare della morte. E di nuovo, ciò che muove la sua penna è la morte intellettuale: l’incapacità di reazione, l’anestesia collettiva a “gas esilarante” che ci rende morti da vivi ad assistere inerti al passaggio del “cadavere di Utopia”.
All’indomani della caduta del muro di Berlino, e agli albori del ventennio che ci avrebbe attesi, Fabrizio De André fotografa l’Italia che cominciava a essere e che sarebbe diventata: quella di oggi con “le troie di regime” che si rifanno il trucco e “le regine del «tua colpa»” che affollano i parrucchieri. Ogni click è “una goccia di splendore”: “dalla bottiglia di orzata / dove galleggia Milano”, al “Voglio vivere in una città / dove all’ora dell’aperitivo non ci siano spargimenti di sangue / o di detersivo”, da “Quant’è bella giovinezza / non vogliamo più invecchiare” fino ad arrivare proprio alla “pace terrificante”, cioè “l’indecenza della non rabbia, della non bestemmia, della rassegnata assuefazione” – come ha spiegato lo stesso De André a Cesare Romana – che è sullo stesso piano, per complicità, dell’indecenza del potere.
3.
In un gioco d’incastri come quelli della prima infanzia, per certi versi, la civiltà fantasma descritta nella Domenica delle salme rappresenta il pieno perfetto e spaventoso del vuoto di una città fantasma. Perché nella satira di De André, al contrario di Bodie, le donne e gli uomini ci sono tutti: nessuno è andato via, sono lì – siamo lì – fermi, con le pance piene, circondati da comodità insulse, convinti da qualcuno che l’oro da preservare sia quello. I pochi che ancora si muovono – gli “ultimi viandanti” – si ritirano presto anche loro, “nelle catacombe”: in un luogo di morte. Quanto di più lontano ai giorni nostri dalle piazze vive di Tunisi, del Cairo, di Tripoli, popolate dalle ragazze e dai ragazzi che invocano libertà, mentre da noi – continuando col testo – “il ministro dei temporali / in un tripudio di tromboni”auspica democrazia “con la tovaglia sulle mani e le mani sui / coglioni”.
La ferocia della satira non risparmia nessuno: tutti, anche quelli che si credono assolti – riecheggiando la Canzone del maggio – sono “lo stesso coinvolti”. Compresi quelli che avevano “voci potenti / adatte per il vaffanculo” e hanno smesso di battere la lingua sul tamburo.
Col suo graffio, De André si oppone alla resa, ricordando agli uomini la loro centralità, e continuando così il racconto – la narrazione – in “direzione ostinata e contraria”. Quel racconto rappresenta a tutt’oggi una miniera di consapevolezza, e di bellezza, da cui ripartire e con cui bisogna “bloccare la fatiscenza”. Una risorsa inesauribile che sta lì, in attesa di un cenno qualunque di risveglio, a guardarci dai “paesi di domani”.
***
Da segnalare l’approdo nella “bottiglia di orzata” della mostra Fabrizio De André: un percorso, tra le sue vicende personali e artistiche, già apprezzato in altre città italiane.
Milano, Rotonda di via Besana – 11 marzo – 15 maggio 2011